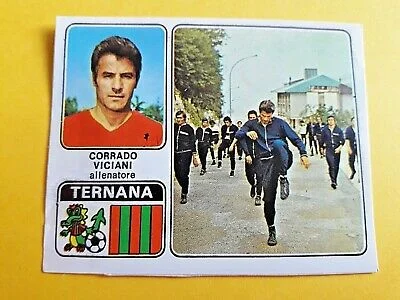Ferrini, Tagnin, Bedin, Lodetti, quelle vite da mediano
La fatica, la pena, la corsa, l’impegno costante. Correvano alla corte di supreme soubrette reggendone il gioco prezioso di pacate vedette. I militi ignoti del sacrificio assoluto, muscolare, immolati sull’altare dei divi.

Precedettero il canto di Ligabue quei giocatori col numero 4 sulla schiena. Quelle vite da mediano. La fatica, la pena, la corsa, l’impegno costante. Correvano alla corte di supreme soubrette reggendone il gioco prezioso di pacate vedette. I militi ignoti del sacrificio assoluto, muscolare, immolati sull’altare dei divi.
Correva Ferrini spoletta inesausta per ricucire la tela e il mito del Grande Torino negli anni vaghi della squadra granata dopo Superga. Sedici anni di corse. Da Atlante triestino si caricò sulle spalle il Torino di Lancioni e Moschino, di Baker e Law, di Bearzot, di Puia e Poletti. Dopo l’immensa fatica, carico d’anni, si ritirò a guardare la vittoria del Torino campione di Puliciclone, di Sala e Graziani negli anni Settanta. Il suo lavoro incessante preparò il team deflagrante dell’anno ruggente.
L’alessandrino Tagnìn e il veneto Bedìn reggevano il campo dell’Inter di Herrera. Una vita severa. Dopo, apparve con superiore eleganza il pratese Bertini di bella baldanza. Assatanati mediani, tappavano falle e innalzavano muri, duri a morire. Opponevano il petto all’avversario insidioso. Cadendo, risorgendo di getto, riprendevano a correre con la forte coscienza dell’emergenza.
Nei derby a Milano, Bedìn stringeva la mano a Gianni Rivera. Poi, per l’intera partita, gli cingeva la vita, gli saltava sui piedi, il fiatone sul collo del disgustato abatino.
Tagnìn, storia vera, giocava d’inverno con la panciera di lana. Nel bosco viennese Herrera gli affidò la marcatura severa di Alfredo Di Stefano madrilena saetta. Tagnìn non lo mollò mai, i suoi capelli di stoppa incollati alla groppa dell’asso argentino.
Mai si fermava Giovanni Lodetti col mento sporgente. “Basletta” nel Milan era un corridore esauriente. In cinquecento partite, andando e venendo, correndo, correndo, fece il giro completo del mondo. Andando nel vento perdeva i capelli. Rientrando dal vento a fine partita sembrava un vecchio eremita. Il pallone gli scavava la faccia, la fatica gli succhiava il viso senza un sorriso. Scudiero di Gianni Rivera, per dieci anni non accusò mai gli affanni della sua corsa perenne. Al bel capitano e ai tanti campioni del Milan offriva i polmoni. Bandiera di servizio la progressiva calvizie. Cantava con Jimmy Fontana la canzone del suo continuo ardimento. Il mondo (diceva quel canto) non s’è fermato un momento.
A sessant’anni compiuti, calvo, il fisico da bancario, non più straordinario, correva ancora Lodetti sui campi imperfetti del sabato sera. Bastava un cenno, tra amici. Al Parco Trenno l’impegno giocondo perché continuasse il giro del mondo.
Nel Milan del primo scudetto con Rivera e Altafini s’annunciò un mediano perfetto. Un ragazzo di Cusano Milanino, quinto figlio di un contadino al tempo in cui Cusano era a mezz’ora di tram da Milano, una distesa di orti e di prati. Giovanni Trapattoni suonatore di ottoni nella banda paesana e ragazzo di tipografia della periferia ambrosiana. Fu visto giocare da quei tipi un po’ misteriosi, la sigaretta tra i denti, che battevano i campi e gli oratori per scovare talenti. Il sodo biondino di Cusano Milanino piacque a un signor Crippa milanista che non lo perse di vista. L’uomo portò il suonatore d’ottoni poco più che ventenne tra i campioni di un incredibile accrocco: Gipo Viani e Nereo Rocco.
Il piccolo Trap, svelto e altruista, fu apprezzato per il gioco essenziale, mediano di servizio senza il vizio di trattenere il pallone. La fortuna lo baciò nel millenovecentosessantatrè: fermò due volte Pelè. L’anticipo era la sua arma migliore.
Un elegante, vigoroso signore del centrocampo. Una lunga carriera e due hobby speciali: i viaggi spaziali (affascinato da Yuri Gagarin) e le sinfonie di Beethoven (gli piace la Nona a quel mona, diceva Rocco il paròn).
In quegli anni dei miei ricordi antichi, il battitore libero, spazza-tutto alle spalle dell’intera difesa, ebbe un primo osannato protagonista.
Il livornese Picchi di nome Armando non era un gigante, ma un bell’omarino di un metro e settanta, il torace di un cardellino, aveva due tronchi di gambe e giocava di fino. Del castello dell’Inter, tutto un maniero merlato, fortemente sbarrato, possedeva la chiave con cui chiudeva alla squadra osteggiata l’ultima entrata. Picchi l’Armando avea l’arte del comando. Dirigeva l’intera difesa e nessuno passava dove Picchi giocava.