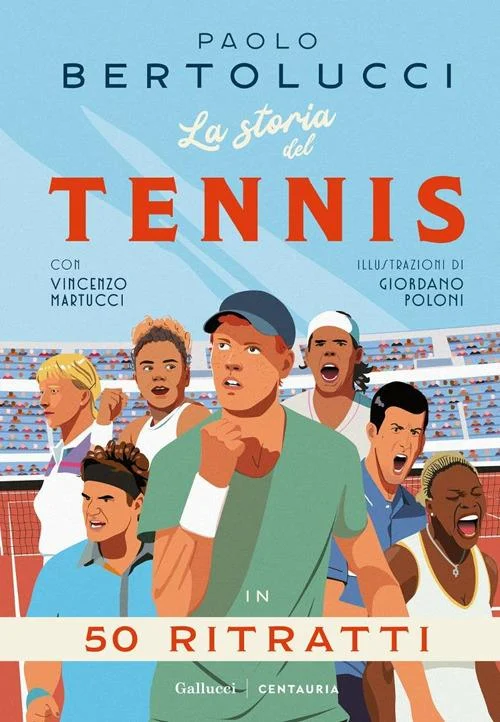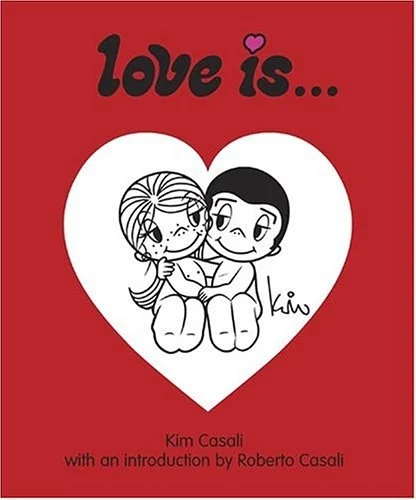“Nei miei film inquadro i personaggi di nuca, perché non sono disposti a guardarsi in faccia”
Intervista al giovane regista Gabriele Di Sazio, che da Los Angeles si sta mettendo in mostra tra premi indipendenti: "Mi interessano le relazioni tra le persone"

“Sin dall’adolescenza ho sentito una forte spinta a esplorare posti nuovi e vivere realtà diverse da quelle a cui ero abituato. Di mettermi in gioco e non rischiare mai di sentirmi a mio agio, e di accontentarmi di un certo tipo di vita, solo perché non ne conoscevo altre. Ho lasciato quindi l’Italia a diciannove anni per trasferirmi a Londra, dove ho vissuto per cinque anni. Ho poi scelto gli Stati Uniti principalmente per le molte opportunità, e la consapevolezza che se fossi stato accettato in una scuola come l’NYU di New York o l’AFI di Los Angeles, sarei entrato in contatto con tantissima gente talentuosa proveniente da tutto il mondo”.
“Per rispondere a questa domanda, vorrei raccontare brevemente della mia esperienza in una delle proteste organizzate da Black Lives Matter. Una marcia di migliaia e migliaia di persone per diversi chilometri, che, arrivata quasi alla fine, si è fermata a Hollywood Boulevard, davanti al Chinese Theatre – vicino agli Oscar, per intenderci – dove tutti i protestanti – ogni singola persona – si è messa in ginocchio ed è stata in silenzio per quasi nove minuti. Immaginate, un fiume di gente, in una delle strade più famose di Los Angeles, in ginocchio e in completo silenzio. Fondamentalmente non so quale sia il vero problema degli Stati Uniti. Tuttavia è certamente molto più complesso di quanto spesso venga raccontato in Italia, e credo che la militarizzazione della società sia soltanto una conseguenza. Le cause probabilmente risalgono alla loro storia sanguinosa e alla schiavitù, un argomento affrontato quotidianamente nei dibattiti interni, e spesso presente anche quando non viene menzionato apertamente. È questa la ragione che mi ha portato a dirigere un cortometraggio (“Focus” appunto) che affronta il problema della violenza della polizia contro gli Afro-Americani, ma senza avere la pretesa di comprenderla o spiegarla. Il film infatti si concentra sulle conseguenze che si abbattono sul figlio autistico di un uomo rimasto ucciso mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa. Il bambino – di appena dieci anni – a un anno dalla morte del padre, comincia gradualmente a capire le conseguenze emotive, sulla madre e su stesso, di quella tragedia e la profondità di quell’inutile vuoto causato da un fenomeno che continua a uccidere tantissimi Afro-Americani ogni anno”.

“Come detto, desideravo scoprire posti e realtà nuove. L’American Film Institute in particolare è uno dei Master di Cinema più importanti e famosi al mondo. Al mio primo giorno abbiamo avuto una Master Class con Quentin Tarantino, e nel corso dei due anni e mezzo che ho trascorso lì ho avuto modo di seguire lezioni che ospitavano personaggi come Guillermo Del Toro, Paul Thomas Anderson, Paul Schrader, Damien Chazelle, Denzel Washington, Sofia Coppola, Darren Aronofky, Ari Aster, Luca Guadagnino e altri. E benché non sia particolarmente interessato al Cinema Americano mainstream, essere nel cuore di Hollywood ti dà l’opportunità di conoscere tantissime persone del settore con cui collaborare e creare storie”.
“In realtà ho ricoperto il ruolo di aiuto regista principalmente per cortometraggi e video musicali. Quando vivevo a Londra ho lavorato con un giovane regista Palermitano, Roberto Prestia, per un lungometraggio low budget dal titolo “Shapes” e, se non ci fosse stata la pandemia, avrei lavorato ad un altro lungometraggio a New York scritto e diretto da un altro giovane regista, Bandar Albuliwi, che ha frequentato l’AFI circa dieci anni fa. Il progetto tuttavia è stato spostato a marzo 2021”.
“Ho appena scritto un film dal titolo ‘Altrove’ – un lungometraggio ambientato tra San Francisco e la Sicilia – che definirei una dramma nostalgico ispirato a un frammento della mia infanzia. In generale mi ritrovo spesso a scrivere storie che girano attorno a famiglie distrutte che tentano di rimettere i pezzi insieme, senza mai davvero riuscirci. Tali storie sono basate sui personaggi e non sulla trama, e presentano vicende e situazioni realistiche che convivono con elementi surreali o di fantasia. Come per esempio un cortometraggio che ho girato anni fa (“Jay”) il quale parla della separazione di una coppia sposata, il tutto visto attraverso gli occhi dell’amico immaginario del figlio di otto anni. Sono interessato alle relazioni tra le persone, e la relazione che ognuno di noi ha con sé stesso; quello che siamo disposti a vedere e sentire ed accettare di noi. Un’inquadratura ricorrente dei film a cui lavoro è il primo piano sulla nuca dei personaggi, i quali spesso sono persone che non sono disposte a guardarsi in faccia. E allora la telecamera – che nient’altro è che la manifestazione emotiva dei personaggi che segue – con frustrazione spesso non riesce a vederli, e lascia che si nascondano agli occhi dello spettatore, come loro si nascondono da loro stessi”.
“Direi che entrambi gli elementi convivono in una sorta di equilibrio. Uno dei miei registi preferiti è John Cassavetes, che ha scritto e diretto film come Faces, A Woman Under the Influence e Husbands. Alla base del suo cinema c’è una scrittura spesso molto precisa basata su un’idea di fondo che viene poi approfondita e modellata attraverso il lavoro con gli attori, specie durante le prove. Grazie a lui ho sviluppato un tipo di regia che si appoggia molto sull’improvvisazioni, a cui però cerco poi di dare ordine nella scrittura e riscrittura della sceneggiatura. In questo modo l’idea originale viene sempre migliorata grazie agli istinti degli attori che – se sono bravi e lavorano con sincerità – riescono sempre – sempre – ad aggiungere autenticità al loro personaggio. A quel punto la riscrittura è un modo per implementare in maniera organica i nuovi elementi all’interno della storia”.
“Dipende. Se il genere nasce prima dell’idea – il che succede più spesso di quanto si possa immaginare – allora penso sia sicuramente una gabbia che limita tantissimo, perché porta a seguire degli elementi specifici. E anche se si dovesse andare contro quegli elementi, si sta comunque seguendo un modello ben preciso che porterà alla realizzazione di un film che, chissà, potrebbe pure risultare rivoluzionario, ma sempre in relazione al suo genere e non in maniera assoluta. Se invece il genere viene usato per descrivere il film, penso funzioni meglio, specie a livello di marketing. Tuttavia mi ritrovo sempre ad essere più interessato a film che non rientrano in alcun genere. Sono spesso più sorprendenti e liberi”.
“Le mie storie sono sempre legate in qualche modo all’Italia ed in particolare alla Sicilia, quindi mi viene difficile pensare che la mia carriera sarà interamente negli USA. La nostalgia di casa mi accompagna sempre in ogni cosa che faccio e spero di avere la possibilità in futuro di lavorare anche in Italia”.