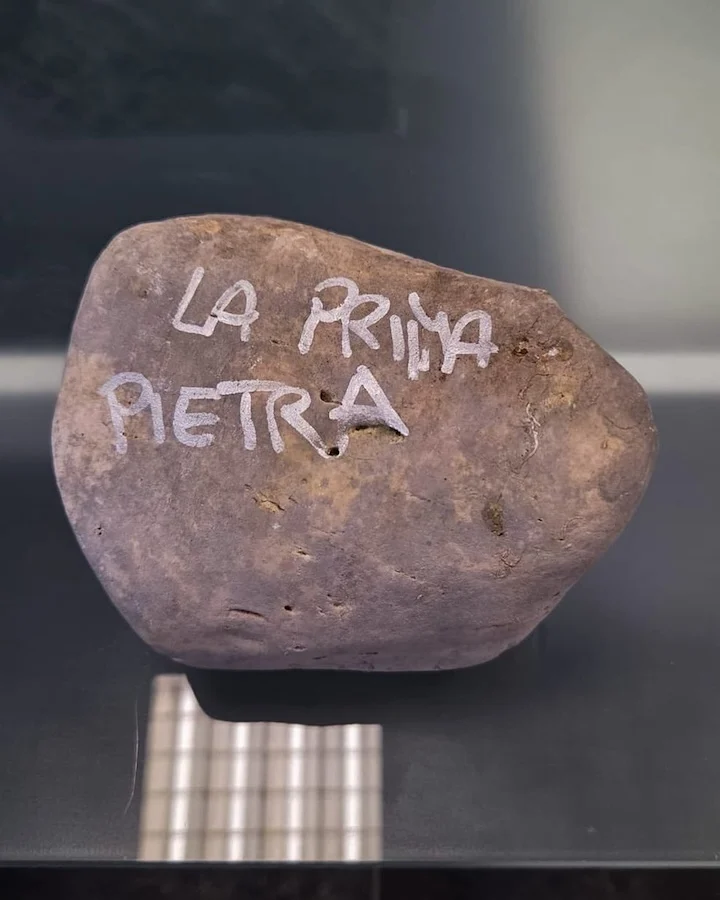Perché tifo Argentina
Parafrasando John Kennedy, potremmo affermare che “siamo tutti albicelesti”. Almeno noi napoletani, calcisticamente parlando. Meglio tenere fuori dal discorso ogni considerazione storico-politica, sociale, geografica, civile che pure sarebbe meritevole di un qualche approfondimento. Non è questa la sede per discutere di Regno delle due Sicilie, Garibaldi, Cavour e Lega Nord o per rievocare Tortora, Moro, Pecorelli, Dalla Chiesa, Calvi, Falcone o Borsellino. Qui si discute semplicemente di passione calcistica. Anche perché, meglio sgomberare immediatamente il campo da equivoci, il Paese di cui si discetta, l’Argentina, qualche problemino, nella sua storia più recente, pure l’ha avuto. Per cui, pure Videla, i colonnelli, Galtieri, i desaparecidos, i voli della morte e le isole del silenzio di cui abbiamo letto con orrore nei libri e negli articoli di quello straordinario narratore che è Verbitsky, i mondiali del ’78, disputati tra torture e bagni di sangue, li terremo da parte perché non funzionali al discorso. E’ innegabile che il responsabile di questa infatuazione che contraddice il nativismo sia Diego Maradona. Ma non solo. Se, in giro per Napoli e provincia, ci sono le bandiere argentine issate su balconi e terrazze, se il merchandising albiceleste va a ruba nei negozi specializzati, c’è qualcosa che va oltre il Pibe de oro. C’è un desiderio di appartenenza calcistica che la Federazione italiana non riesce più a soddisfare da quando ha deciso di tollerare i cori di discriminazione territoriale, gli inviti al Vesuvio a seppellire un popolo intero sotto una coltre di lava e cenere. Se a tutto questo si aggiungono campionati e coppe il cui esito è determinato da errori arbitrali macroscopici, la discutibile gestione della squadra nazionale con convocazioni tese a soddisfare le esigenze dei club più potenti e blasonati, la questione dei diritti televisivi e dei conseguenti conflitti di interessi che vi ruotano intorno, è facile intuire che il richiamo al cosmopolitismo illuministico, in contrapposizione allo scontato nativismo, non è un semplice capriccio o una moda da radical chic appassionati della prosa di Soriano o della poesia di Borges (che peraltro odiava il calcio). Al contrario, c’è chi decide di essere vittima e chi sceglie di non essere complice. C’è chi decide di sventolare il tricolore acriticamente durante i mondiali o i campionati europei e c’è chi rivendica a buon diritto una diversità, dolorosa e ragionata. C’è soprattutto chi ricorda che il primo scudetto affonda le sue radici nel trionfo di Maradona al mondiale dell’86 quando condusse la sua squadra alla vittoria con giocate memorabili. Diego tornò a Napoli con la corazza dell’invincibile, col mantello del capitano indomabile che non si rassegnava ad un destino già scritto. E dieci mesi dopo completò il capolavoro. Vinse dove non si era mai vinto, dove ci si era abituati ad essere soggiogati, non solo nel calcio, da vecchi e nuovi padroni. Per una volta, era Napoli a dettare a legge. A vincere lo scudetto. Anzi ne vinse due. Il secondo nel 1990 alla vigilia del mondiale italiano. Quello che doveva concludersi con il successo della simpatica squadra di Vicini ed, invece, si concluse tra incredulità e lacrime proprio a Fuorigrotta. L’Italia uscì per mano di Diego. Napoli visse una crisi di identità quella sera. Il tifo per l’Italia fu tiepido. Maradona fu abile ad insinuare il dubbio prima della partita. «Gli italiani devono capire che il napoletano è anche italiano. Pretendo il rispetto per i napoletani, non il tifo per l’Argentina», tuonò il Pibe de oro nell’immediata vigilia con un’eccezionale abilità comunicativa. Bruciavano ancora i riferimenti alla monetina che colpì Alemao, le accuse a Carmando, quel Napoli “campione del Nord Africa” che fu stroncato dal sarcasmo geniale di Massimo Troisi come “una battuta da Sudafrica”, il Paese in cui regnava quella forma abominevole di segregazione razziale chiamata aparthied. Il San Paolo, beffardamente, fu il Tribunale supremo che cancellò l’onta e fece giustizia di quella caterva di insulti. Anche per questo il 3 luglio 1990 cambiò il rapporto di alcuni napoletani con la propria Nazionale come non era mai successo prima. Ed oggi, a ventiquattro anni di distanza, una parte di Napoli rivendica una sua autonoma diversità, si identifica solo nell’azzurro della squadra della propria città e nel celeste argentino. Si riconosce nel tormentone estivo “Brasil decime que se siente”, una canzonatura che ricorda l’indimenticato “Giulietta era zoccola”, urlato a squarciagola e fino alla noia con gaudente orgoglio dagli argentini a zonzo in terra carioca. Quella goliardia colorata rimanda molto al tifo partenopeo degli anni ’80 quando ancora le coreografie prevalevano sulla coerenza e i cori sulla mentalità. Quando al razzismo si rispondeva con messaggi caustici e l’odio era appannaggio solo di quella parte d’Italia livorosa ed anche un po’ invidiosa. Ergo, appare più coerente, ora più che mai, l’appoggio convinto, anche se lacerante e tranciante, a Higuain e Lavezzi con i quali, peraltro, è più facile un processo di immedesimazione che, al contrario, risulta arduo, se non impossibile, con i tanti juventini che vestono la maglia della Nazionale, non tutti con merito. Certe ferite fanno fatica a rimarginarsi. La Supercoppa di Pechino e la conduzione di gara di Mazzoleni sono difficili da scordare, così come l’antipatico e ridondante appello ad usare l’acqua e il sapone e la terribile disorganizzazione della finale di Coppa Italia. Sostenere quella che si è rivelata un’armata Brancaleone più che una squadra di calcio avrebbe significato in qualche modo, seppure involontariamente, avallare le sciagurate decisioni di Prandelli e legittimare la discutibile conduzione settennale di Abete.Tutte argomentazioni che meriterebbero un approfondimento schietto, un confronto leale. Quando un fenomeno inizia ad avere una diffusione non trascurabile, va analizzato in profondità. Le alzate di spalle piccate ed infastidite sono controproducenti perché archiviano il problema senza affrontarlo. Non devono esistere argomenti tabù né posizioni integraliste. Soprattutto quando si discute di calcio. E, come in ogni situazione, anche quelle di maggiore rilevanza, non conviene mai prendere la vita troppo sul serio. Gianluca Spera