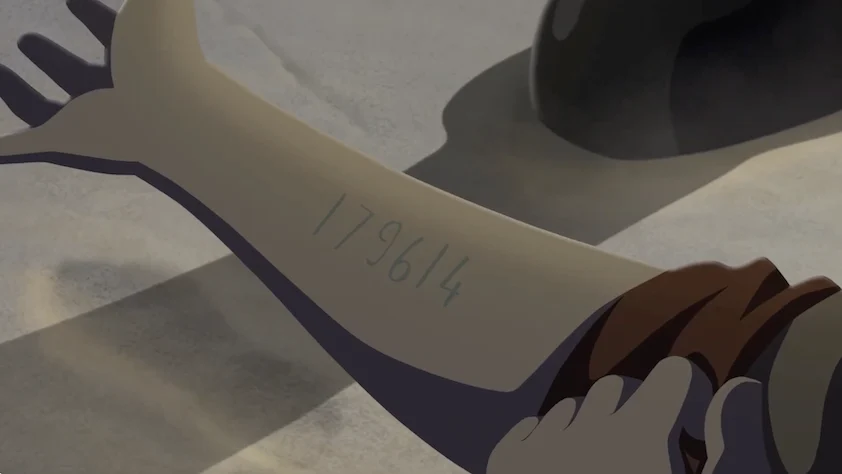Ron: «Ho da sempre problemi di memoria legati all’ansia, da bambino prendevo medicine per concentrarmi»
Al CorSera: «Ore con mia madre a studiare e la mattina, a scuola, tabula rasa. I miei erano preoccupati per quel figlio 'stranetto'. Dimentico anche i testi delle mie canzoni».

Il Corriere della Sera intervista Rosalino Cellamare, in arte Ron. Racconta i suoi problemi di memoria, che si porta dietro da quando era bambino.
«Sono smemorato. La memoria è sempre stata il mio lato debole. Da bambino prendevo le medicine per migliorare la concentrazione. E non riuscivo a mettermi in testa le poesie. Un incubo. Ore con mia madre a studiare. La mattina a scuola, tutto cancellato, tabula rasa. La maestra mi guardava negli occhi: “Rosalino ripeti Davanti San Guido!”. Quattro righe e calava il vuoto. Un altro incubo sono i testi delle canzoni durante i concerti. Sì, anche quelli di cui sono autore».
Ha un suo metodo per risolvere il problema, durante le esibizioni dal vivo.
«Devo avere tutto scritto davanti a me. Una specie di “gobbo” a cui aggrapparmi in caso di necessità. Il racconto a braccio, a ruota libera mi viene facile, mi è congeniale. Ricordare, invece, è una fatica. Dovuta a una forma d’ansia: la paura di sbagliare. Infatti, sbaglio. Sono talmente distratto che non riesco a evitare gli errori anche se sto leggendo. Reinvento le parole, a volte. E talvolta miglioro il risultato finale. Sono fatto così, non so che fare…».
Da ragazzino era timido ma terribile.
«Timido sì, ma terribile. Sui 12-13 anni, facevo certi scherzi agli amici… Un po’ Pinocchio e un po’ Lucignolo. Stavo per ore sotto il letto. Immobile. Guardavo la rete, il materasso. Ero sereno. Pensavo. A scuola andavo malissimo. Un asino pazzesco. I miei genitori erano preoccupati per quel figlio un po’ stranetto. Così mi misero in collegio, a Saronno. Studiavo da geometra».
E’ cresciuto in provincia, a Garlasco, Pavia. Racconta l’atmosfera, dove non ci si sentiva mai soli, circondati da famiglie amiche.
«Un mondo semplice: si mangiavano le cose della terra, dell’orto. Papà era un commerciante di olio d’oliva. I Cellamare sono originari di Trani, in Puglia. Mio nonno venne al Nord, a Milano, a 18 anni. Mia nonna era una mondina, andava alla fabbrica del tabacco, lavorava sempre, aveva tre figli. Era contenta di quello che faceva, si accontentava. L’andavo a trovare quasi tutti i pomeriggi. Mi preparava il tè con le ciambelle di Pavia, i brassadè, una ricetta di oltre cent’anni fa. Ricordo i suoi racconti sulla guerra, anzi sulle due guerre. Se non ci fosse stata lei, non avrei scritto Attenti al lupo».
Spiega:
«Andandola a trovare mi accorsi che la casa aveva una finestra più piccola. Mi sedetti al pianoforte e scrissi: C’è una casetta piccola così / Con tante finestrelle colorate / E una donnina piccola così/ Con due occhi grandi per guardare. In origine la canzone si chiamava proprio La casetta. Mi piaceva ma la sentivo troppo personale. Decisi che non sarei stato io a cantarla. Pensavo a Dalla. O a Celentano: mi sembrava avesse la tenerezza giusta. Lucio venne da me mentre preparavo il mio album. Mi chiese: “La fai, Rosalino?”. “No”, risposi. “Allora la faccio io: con questa, vendiamo un milione di dischi”. Aggiunsi: “Sei matto, il solito sognatore!”. Aveva ragione lui. Di dischi ne abbiamo venduti ben di più».
Ha partecipato ai primi concorsi musicali grazie alla sua insegnante di pianoforte e canto. Grazie alle sue esibizioni qualcuno si accorse di lui. Fu convocato a Roma da un misterioso cantautore.
«Presi il treno con papà. Arrivati, ci fecero attendere per ore. Nella sala d’aspetto, a un certo punto, entrò un tipo eccentrico, con una tutina stretta di leopardo. Si presentò a mio padre: ciao, Nì. Era Renato Zero. Non lo conoscevo: allora ascoltavo solo musica americana, Crosby Still & Nash, Cat Stevens, James Taylor. Papà mi guardò storto: voleva scappare. “Questa è una gabbia di matti”, mi disse. Di lì a poco, arrivò il cantautore. Era ingessato, aveva appena avuto un incidente con la moto sul Raccordo Anulare. Era Lucio Dalla. La canzone che aveva da propormi era Occhi di ragazza, davvero bellissima, che fu più tardi portata al successo da Gianni Morandi. Avrei dovuto cantarla a Sanremo in coppia con Sandie Shaw, la cantante scalza, ma le giurie la ritennero non idonea. Così ripiegai su Pa’ diglielo a ma’».
Molto tempo dopo, Morandi scoprì che quella canzone inizialmente non avrebbe dovuto cantarla lui.
«Un giorno molto tempo dopo venne da me Morandi, diventato un amico. Mi prese da parteechiese: ma quella canzone di Lucio che dovevi cantare era Occhi di ragazza? Sai, lui m’aveva detto che l’aveva scritta per me. Dalla era un gran bugiardo. Nel senso buono, eh. Un ottimista che amava confezionare i suoi racconti, immergerli in una sorta di realtà aumentata. Inseguiva la bellezza, la narrazione fantastica. Gli piaceva rendere la vita più interessante di quello che era. Come Fellini. Ogni volta, uno show, un esercizio di creatività. Diceva di aver fatto un viaggio in treno con Totò in cui avevano riso senza fermarsi un istante, di aver incontrato gli ufo e di averne visto uno che avanzava verso di lui e poi, improvvisamente, aveva cambiato rotta».
Negli anni Settanta arrivò un momento di buio, complici gli anni di piombo.
«Vennero anni di buio totale. Mi misi a suonare per gli altri, non mi sentivo sminuito. Non ho mai pensato: io sono Ron e non posso accompagnare De Gregori o Venditti. Ma dentro di me mi chiedevo chi avesse spento la luce. Tornare indietro mi sembrava un fallimento».
A salvarlo fu il tour con Dalla e De Gregori, “Banana Republic”.
«Ogni sera, sold out. Prendevo tanti fischi. Tutti aspettavano Lucio e Francesco. Io proponevo I ragazzi italiani. Il pubblico non ne voleva sapere, la maggior parte mi aveva dimenticato. Ma io ero felice. Lì nacque il progetto ‘Una città per cantare’ e io ripresi a pieno ritmo».