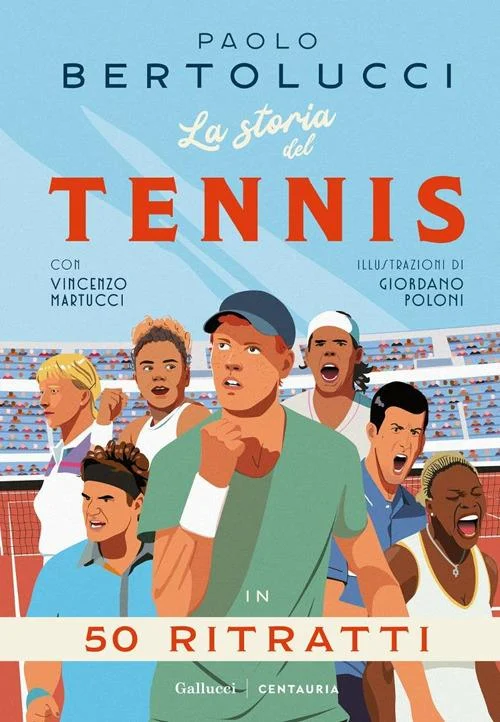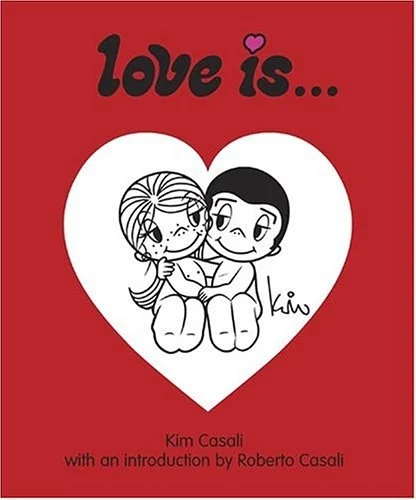Ho visto Maradona: il racconto del Mondiale Under 20 del 1979
Alla vigilia dei Mondiali Under 20 in Corea del Sud, il Napolista ha rivisto per i suoi lettori alcuni filmati d’archivio risalenti al 1979.

“Quando ha cominciato a capire di essere Maradona?”.
“A diciannove anni ho vinto la Coppa del Mondo Juniores in Giappone, ed in quel momento ho capito che potevo fare di più con la forza che avevo, allenandomi meglio in una squadra più forte. Sin da piccolo volevo solo il pallone, era il mio giocattolo preferito, non pensavo a nient’altro che a quello”.[Diego durante ‘L’Intervista’ di Maurizio Costanzo, 26 gennaio 2017]
Giappone
Il sempre solerte comitato esecutivo della Japan Football Association non avrebbe potuto chiedere di meglio, quando fu incaricato da João Havelange di promuovere una rassegna che avvicinasse a questo sport il sino a quel momento restio pubblico nipponico. Oscurato da sumo, lotta libera, arti marziali, pallavolo e baseball, il rotolio della sfera di cuoio sul manto erboso faticava ad attecchire nell’immaginario di un popolo appena scalfito dall’intraprendenza del tedesco Dettmar Cramer, visionario precursore dietro il cui lavoro si celavano le uniche soddisfazioni in ambito olimpico di un movimento nazionale immune al professionismo, ed incapace finanche di partecipare alla Coppa d’Asia sino al 1988.
A lanciare un sasso in quella palude d’indifferenza stagnante e impenetrabile contribuì alfine la seconda edizione del Fifa World Youth Championship, sedimentatasi nella memoria collettiva grazie alla presenza di una compagine schiacciasassi, forse la più spettacolare mai ammirata a questi livelli insieme alla generazione d’oro jugoslava che dominò in quel di Santiago all’imbrunire degli anni ottanta; l’impressionante score di sei vittorie in altrettante partite disputate, nobilitato da un bottino di ben venti reti realizzate ed appena due subite, rappresentano solo in parte un impatto mediatico e per certi versi culturale senza precedenti all’ombra del Sol Levante.
Ho visto Maradona “inventarsi” Holly e Benji…
Non è un caso che la narrazione del celeberrimo manga Captain Tsubasa, fondamentale per diffondere di lì a poco il verbo calcistico nel tessuto sociale autoctono, fosse incentrata principalmente su tale tipologia di manifestazione, ignorando le gesta dei grandi.
Pleonastico poi sottolineare il modo in cui la spensieratezza ed il gioioso approccio al gioco dei ragazzi argentini conquistarono i cuori dei tifosi rimasti in patria, pronti a svegliarsi all’alba tra Buenos Aires e dintorni pur di supportarne il trionfale cammino transcontinentale; reduce dalle scorie del famigerato ‘Mondiale della Vergogna’ casalingo, César Luis Menotti riuscì con la sua rara sagacia a ripulire l’immagine dell’Albiceleste nel sacro lavabo del panorama giovanile, riscuotendo stavolta unanimi consensi. Va ricordato quanto sino alla parabola seminale da lui avviata nei Seventies, il puntino dell’Argentina quasi non esistesse sulla cartina internazionale dal punto di vista competitivo, se si eccettuano gli estemporanei exploit di Luis Artime e soci tra Londra e Montevideo o le epiche ed ormai sbiadite imprese tra campo e panchina del filtrador Guillermo Stábile a cavallo tra i due conflitti mondiali.
Quando cambiano le coe
L’autentico spartiacque storico per le sorti della Selección va rintracciato nel Festival Espoirs de Toulon 1975, prima tappa di un lungimirante percorso organizzativo approntato per incanalare sui binari della concretezza l’estro anarchico dei talenti più fulgidi scovati in giro per il Paese dal fido sodale Ernesto Duchini; mentre i premi individuali si concentrarono sulle prodezze del messicano Hugo Sánchez, la generosità dei francesi Maxime Bossis e René Girard, o l’intesa condita da virtuosi effetti speciali tra Walter Alfredo Novellino, nominato Joueur Le Plus Élégant della rassegna, e Roberto ‘Dustin‘ Antonelli (la porta italiana era protetta da un misconosciuto, sgraziato ma efficace guardiano dei pali che stava sorprendendo tutti in quel di Casale e che rispondeva al nome di Claudio Garella…), l’inedito pragmatismo palesato dai sudamericani permise finalmente di superare in malizia quello scoglio europeo apparso insormontabile sino a quel fatidico appuntamento.
La Seleccion sbaragliò col minimo sforzo (tutti gli incontri furono vinti col medesimo punteggio, uno striminzito 1-0) la concorrenza grazie alla puntualità realizzativa di Jorge Valdano ed il raziocinio garantito da Daniel Passarella, Alberto Tarantini e Américo Gallego, solido terzetto equilibratore anche durante la succitata conquista dell’alloro iridato tre stagioni dopo.
1979
Da ben altra musica poterono lasciarsi ammaliare i fortunati osservatori inviati in Estremo Oriente nel 1979 rispetto ai testimoni presenti sul suolo transalpino: se lo spartito strategico restava ancorato a quel 4-2-4 importato nel subcontinente dai maestri magiari nel Dopoguerra, stavolta alle spalle del fromboliere di turno schierato da centravanti di manovra (Ramón Díaz, stellina nel River Plate, indiscusso top-scorer con otto centri) agiva da illuminante tuttocampista un Diego Armando Maradona già alla ricerca di rivalse personali.
Nel suo animo battagliero, infatti, bruciava ancora l’esclusione all’ultimo minuto dalla lista-Mundial patita quattordici mesi prima, nonostante si fosse laureato capocannoniere (22 reti, ex-aequo con Luis Andreuchi del Quilmes) nel Campeonato Metropolitano y Nacional appena maggiorenne, incantatore eccelso con la maglia dell’Argentinos Juniors, e certo non erano bastati i saltuari assaggi di Copa América concessigli ad inizio agosto per placarne la sete di vittorie.
L’assegnazione della fascia da capitano lo responsabilizzò ulteriormente, facendone il condottiero ideale di un gruppo in cui l’innocente goliardia regnava sovrana sin dalla marcia di preparazione alla trasferta asiatica, dipanatasi tra una memorabile amichevole a Tucumán con i Cosmos di Beckenbauer e Chinaglia (2-1), passeggiate turistiche tra Hollywood e Disneyland ed interminabili torelli negli allenamenti, in cui Juan José Meza ed il riccioluto impertinente condannavano il povero assistente Rogelio Poncini a rincorse vane e sfiancanti dell’agognata sfera tra le risate irrefrenabili di Kashe, il traduttore accodatosi alla spedizione appena sbarcati a Tokyo.
L’Indonesia ed il gol à la Messi (otto anni prima che Lionel nascesse)
Questo spirito festoso fu il vero segreto del successo finale: la peculiare gestione del possesso, supervisionata in cabina di regia da quel Juan Alberto Barbas allora in forza al Racing Avellaneda ed in seguito inatteso giustiziere della Roma di Sven-Göran Eriksson vestendo i colori di un Lecce già retrocesso, fungeva da presupposto necessario per un fútbol asociativo dai ritmi cadenzati, in cui le improvvisazioni azzardate dal Pibe de Villa Fiorito incoraggiavano i compagni a lanciarsi in campo aperto con accelerazioni fulminee, assecondandone le intuizioni geniali. Esplicativo in tal senso l’andamento del facile esordio contro l’Indonesia (5-0), manzoniano vaso di terracotta in un girone di ferro ed ancor oggi la peggior retroguardia di sempre del torneo, alla luce dei sedici palloni raccolti in fondo al sacco dall’incredulo Endang Tirtana nei tre proibitivi impegni in calendario.
L’ingenuo sistema uomo contro uomo allestito da Soetjipto Soentoro, unito alla latente inidoneità nel seguire i tagli degli esterni avversari, permisero a Díaz di abusare a proprio piacimento degli spaesati Merah Putih, mentre le ubriacanti serpentine di Maradona tra apparenti birilli vestiti di rosso, in particolar modo quando partiva da posizione defilata per accentrarsi penetrando come lama nel burro in area di rigore e concludere verso lo specchio della porta, divennero una sorta di prototipo da imitare in relazione alle due superbe firme d’autore impresse in calce sul tabellino, imperituro marchio di fabbrica in grado di ispirare tutti i sognanti ragazzini che in futuro si sarebbero allacciati un paio di scarpette bullonate ai piedi.
I primi due gol del montaggio sono quelli realizzati contro l’Indonesia.
Ho visto Maradona conoscere la propria nemesi
L’amore a prima vista sbocciato tra quello scrigno senza fondo di magie con la casacca numero dieci sulle spalle e gli entusiasti spettatori dell’Ōmiya Park Soccer Stadium non conobbe cedimenti neanche nel corso del match più difficile, ossia la seconda esibizione al cospetto della Jugoslavia (1-0), col senno di poi la vera finale anticipata in rapporto allo spessore tecnico espresso dai contendenti. Il fraseggio corto nel settore nevralgico del campo proposto dai palleggiatori gravitanti nell’orbita del faro bosniaco Mehmed Baždarević sancì un evidente dominio territoriale delle pedine schierate da coach Ivan Toplak nella frazione iniziale, irretendo sul nascere le fonti di gioco biancocelesti.
Un Diez paradossalmente limitato dal coraggio concettuale dell’unica squadra che non predispose una marcatura fissa su di lui cercò spesso e volentieri di allargare il proprio raggio d’azione sull’out mancino, ma l’inconsueta imprecisione negli appoggi ed un goffo tentativo di superare l’elegante sweeper Ivan Gudelj (fresco MVP dei vittoriosi Europei Under 18 in Austria), ricorrendo ad un’improbabile mano de Dios ante litteram, ne illustrarono meglio di qualsiasi analisi postuma la frustrazione contingente. Per giunta, a guardia del bersaglio grosso vi era la spavalda sicumera di colui che da quel pomeriggio ingaggiò un’ultradecennale guerra di nervi con El Pelusa, uscendone sempre invitto nei singoli duelli benché piegato dalla sorte di fronte ai verdetti conclusivi; la baldanza con cui il croato Tomislav Ivković neutralizzò una splendida punizione d’esterno, infatti, fu solo l’antipasto di un’immaginaria catena di prodezze che tentarono vanamente di frenare l’ascesa di Diego in varie occasioni della sua carriera.
Sporting Lisbona
Resta ancora vivido il ricordo dei balzi felini che sancirono l’incapacità del Napoli campione uscente nel violare la stregata imbattibilità dello Sporting Lisbona tra andata e ritorno nei trentaduesimi della Coppa UEFA 1989/90, così come le urla di giubilo strozzate nelle gole di Careca, Francini, Carnevale e Mauro per accompagnare conclusioni ravvicinate a botta sicura, o gli sguardi titubanti di Crippa e dello stesso Pibe, ipnotizzati dal dischetto nella risolutiva lotteria susseguente a duecentodieci interminabili minuti trascorsi senza lo straccio di una rete.
La prontezza di riflessi dagli undici metri rischiò di rivelarsi esiziale anche nei quarti dei Mondiali ’90 all’Artemio Franchi di Firenze, allorquando soltanto i miracoli dell’omologo tapapenales Sergio Goycochea consentirono all’Argentina di strappare un passaggio del turno piuttosto immeritato, episodi determinanti tanto quanto gli errori di Luizinho, Marlon e Fernando Gomes al San Paolo o la verticalizzazione di Barbas che smarcò in profondità l’ala destra Osvaldo Escudero (Vélez Sársfield) per aggiudicarsi con scarto esiguo l’ingarbugliata contesa in Giappone. Senz’altro i risultati negativi hanno conferito un retrogusto beffardo alle imprese realizzate, ma non tutti possono raccontare di aver abbassato la saracinesca innanzi ad un certo Maradona, parandogli inoltre due calci di rigore nell’arco di nove mesi…
Argentina-Jugoslavia
Ho visto Maradona piangere come un bambino
Archiviato l’insidioso ostacolo slavo, la strada verso il titolo d’incanto imboccò una ripida discesa, benché dietro la netta affermazione sulla Polonia (4-1) si celassero alcuni nodi strutturali emersi non di rado quando c’era da affrontare sistemi tattici maggiormente evoluti, avveduti nell’alternare il consolidato utilizzo del libero (nella fattispecie, il diligente Piotr Skrobowski), all’interno del classico 1-4-3-2 di matrice europea, con taluni abbozzi di difesa a zona.
Peraltro, il pacchetto arretrato imperniato sul rude zaguero Juan Simón (Newell’s Old Boys) non era abituato a coprire in spazi larghi ed interpretare i movimenti ciechi del terzo uomo in ricezione sugli scarichi ad incrociare, ed in quest’ottica gli scambi rapidi tra Andrzej Pałasz e Andrzej Buncol fornirono indicative avvisaglie, precorritrici degli imbarazzi creati dai russi nell’ultimo atto. Fortuna volle che bastassero appena sette giri di lancette a Dieguito per trasformare da par suo una punizione di seconda dal limite dell’area, eludendo in corsa l’uscita disperata di due avversari dalla barriera per poi scagliare un bolide all’incrocio, impedendo a Jacek Kazimierski persino di tuffarsi.
Algeria
La doppietta dell’extremo izquierdo Gabriel Humberto Calderón (Racing) consolidò la vetta nel Gruppo B, mentre sul medesimo versante del tabellone suscitò parecchio scalpore l’andatura dell’Algeria, la cui aggressività sull’altezza delle linee di pressione, ben coordinate da Mohamed Chaïb ed il jolly Djamel Menad, mise in crisi addirittura la Spagna, con la sua attitudine morbida e tutto sommato estetizzante che non riuscì ad arginare le poderose sgroppate in ripartenza di Derradji Bendjaballah e del guizzante Hocine Yahi.
Toccò nuovamente al leader tecnico ed emotivo albiceleste l’incombenza di smorzare la veemenza nordafricana con l’ennesima pennellata da fermo, indispensabile per indirizzare alla mezz’ora un punteggio ancora bloccato dall’ossessivo fuorigioco dei Fennecs, solco primigenio in cui dilagare sfruttando la verve di uno scatenato Díaz ed i suoi tre graffi a chiudere le ostilità con un perentorio 5-0. L’estasi per il raggiungimento delle semifinali fu turbata dalla comprensibile decisione del Flaco di preservare la sua arma prediletta dai vigorosi tackle al limite del regolamento a cui fu sistematicamente sottoposto, sostituendolo anzitempo con Meza: d’altro canto, la rabbiosa pioggia di lacrime che accompagnò quel bimbo insaziabile negli spogliatoi fornì un’ulteriore testimonianza di quanto potesse risultare crudele squarciarne il naturale contatto osmotico con il giocattolo preferito, precludendogli il palcoscenico più amato e soggiogandone l’istinto ludico sotto i rigidi dettami della prudenza.
Ho visto Maradona rinchiuso in una gabbia
La perspicacia di Menotti fu in realtà aguzzata dalla previsione di dover sostenere l’improba tenzone con la proverbiale garra charrúa dell’Uruguay di Rubén Paz e Jorge Barrios, dominatore incontrastato dal 1975 nell’intimo scenario del Sudamericano Sub 20 e reduce da un inequivocabile filotto difensivo inaugurato a gennaio di dieci partite consecutive in cui soltanto il fantasista paraguaiano Romerito aveva assaporato l’effimera illusione di battere l’arquero Fernando Álvez (Peñarol), insuperabile spauracchio per i meccanismi offensivi di Guinea, Ungheria, URSS e Portogallo.
Quell’ardore agonistico mai domo dei satanassi con la camiseta celeste si esaltò vieppiù su un terreno inzuppato dalle copiose precipitazioni abbattutesi sulla capitale nipponica, soffocando le trame manovriere dell’Argentina e l’incedere felpato dei suoi gioielli tecnicamente più dotati; cionondimeno, un inopinato scherzo del destino volle che proprio la scarsa percorrenza della sfera sul rettangolo di gioco accidentato generasse una clamorosa leggerezza in disimpegno di Nelson Alaguich, concedendo ad Escudero l’opportunità di servire un indisturbato Díaz per spezzare alfine l’incantesimo.
El Pelado si rese poi protagonista di una fuga solitaria in contropiede, culminata con un cross col contagiri per l’accorrente gemello, affatto intimidito dal clima bellicoso e lesto nell’esplorare risorse inusitate del suo sterminato repertorio, ovverossia un inusuale colpo di testa mandato ad adagiarsi tra i pali sguarniti, piegando definitivamente la stoica resistenza uruguagia (2-0) e scrollandosi di dosso l’opprimente fanghiglia atmosferica che invano aveva tentato di tarparne le ali.
Argentina-Uruguay
La finale
L’apoteosi si fece attendere settantadue ore: la trappola dell’URSS campione in carica concentrò la propria morsa quasi esclusivamente sul Barrilete Cósmico, ingabbiato sin dal fischio d’inizio dell’arbitro brasiliano José Roberto Wright dall’asfissiante sorveglianza del truce ucraino Anatoliy Radenko, deputato di scortarlo pedissequamente in ogni anfratto del tappeto verde e coadiuvato in seconda battuta dal libero armeno Ashot Khachatryan.
Consapevole dell’improbo compito di ripetere l’inebriante cimento compiuto dal predecessore Masyagin in terra tunisina (1977), il CT Sergei Korshunov varò una formazione particolarmente accorta, caratterizzata da catene dinamiche miranti a garantire almeno otto giocatori dietro la linea della palla in un 1-4-2-3 sui generis, confermando la scelta di rinunciare al promettente Oleksandr Zavarov (in seguito contraddittoria meteora juventina) per affidarsi alle velleitarie sortite di capitan Yaroslav Dumanskyi, sovente in aiuto del troppo isolato riferimento avanzato Oleh Taran, e soprattutto ai lanci lunghi dell’altro mediano Igor Ponomaryov, spesso propenso a capitalizzare in percussione centrale l’asse con il tornante destro Sergei Stukashov. Il sornione diesel sovietico colpì all’improvviso proprio grazie al centrocampista nativo di Baku alla riapertura delle danze nel secondo tempo, costringendo gli argentini a sbilanciarsi e sprecare le residue energie in serbatoio, riversandosi furiosamente nella trequarti opposta.
Lo sforzo fu premiato da un fallo di mano che generò il penalty riconvertito in pareggio al sessantottesimo dal terzino sinistro Hugo Alves (Boca Juniors), ma in special modo contribuì a disattivare gli schemi ridestando così dal torpore tatticistico l’immarcescibile coppia Díaz-Maradona, entrambi preziosi nel far ammattire con finte irridenti e micidiali uno-due i confusi Ovchinnikov, Polukarov ed il subentrato Olefirenko per trafiggere l’incolpevole portiere Viktor Chanov (3-1), futuro baluardo della scintillante Dynamo Kyïv del maestro Valeriy Lobanovskyi.
Argentina-Urss
Trionfo (anche personale)
Le luci del National Olympic Stadium di Tokyo si abbassarono in segno di doveroso rispetto, mentre l’ormai rapito pubblico assiepato sugli spalti aveva imparato ad appassionarsi ad una nuova, straordinaria seppur talvolta incomprensibile disciplina. Nei giorni successivi all’indimenticabile bagno di folla che ne salutò il rientro a Buenos Aires, sarebbe arrivato per Diego il riconoscimento assegnato dal periodico venezuelano El Mundo al Futbolista Del Año En Sudamérica, un onore spettato solo a Mario Kempes tra i connazionali sino ad allora: furono i primi vagiti di un’epopea leggendaria, la più grande che questo sport abbia mai conosciuto.
Durante un’umida estate asiatica la Storia del Calcio cambiò per sempre: in quel lontano 1979 il mondo vide Maradona.